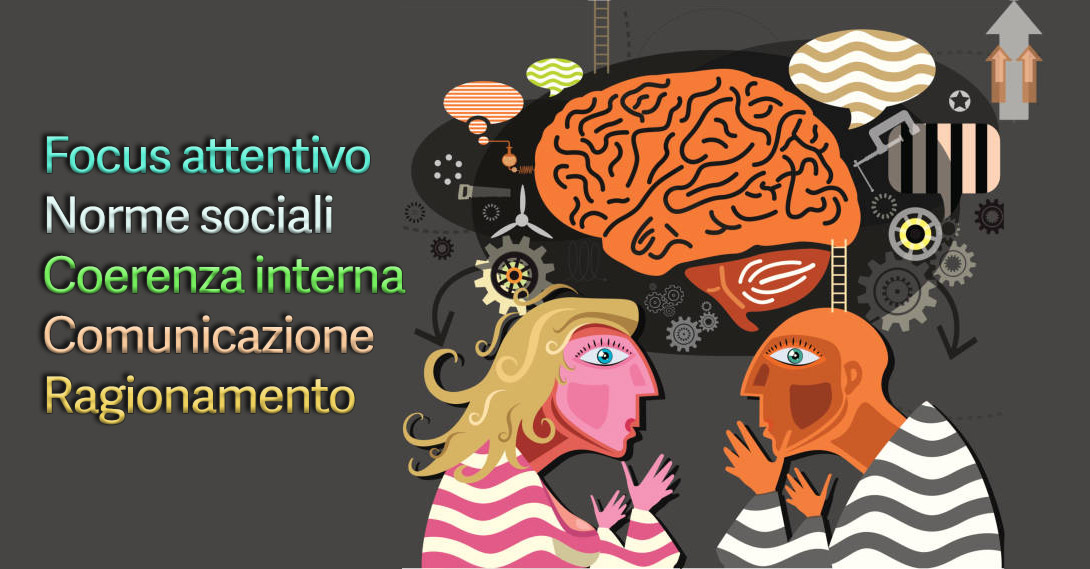 Il termine neurodiversità nasce per sfidare la visione patologizzante della mente umana. Coniato negli anni ’90 dalla sociologa australiana Judy Singer, descrive la naturale varietà nei modi in cui il cervello umano può funzionare. Non si tratta quindi di una “deviazione” da una standard, ma di una diversità neurologica che comprende condizioni che rientrano nello spettro dell’autismo, nell’ADHD e nelle condizioni note come dislessia, discalculia, sindrome di Tourette, e altre.
Il termine neurodiversità nasce per sfidare la visione patologizzante della mente umana. Coniato negli anni ’90 dalla sociologa australiana Judy Singer, descrive la naturale varietà nei modi in cui il cervello umano può funzionare. Non si tratta quindi di una “deviazione” da una standard, ma di una diversità neurologica che comprende condizioni che rientrano nello spettro dell’autismo, nell’ADHD e nelle condizioni note come dislessia, discalculia, sindrome di Tourette, e altre.
Queste modalità cognitive non dovrebbero essere lette come “errori da correggere”, ma configurazioni mentali differenti da integrare; condizioni che comportano modi unici di pensare, percepire, apprendere e sentire. Purtroppo, il contesto sociale, educativo e lavorativo non è progettato per comprenderle ne’ tantomeno per valorizzarle, pertanto genera sofferenze in chi “non funziona” entro determinati standard. Il malessere di chi devia da “norme e modelli impliciti di funzionamento mentale”, infatti, deriva più dal mismatch ambientale che dalla diversità stessa!
Non una nuova etichetta, ma un invito a pensare in modo più libero
Vorrei che imparassimo tutti a pensare alle persone come organismi a sé, con una storia evolutiva personale che li ha portati a essere ciò che sono. Con un background genetico unico che, ogni giorno, si è modellato in un ambiente di sviluppo socioaffettivo altrettanto unico. Siamo tutti uguali se posti sulla bilancia del valore ma siamo tutti diversi se guardati a livello individuale. Ognuno con la sua storia, ognuno con i suoi adattamenti. Sento il bisogno di chiarirlo perché non vorrei mai che la parola «neurodiversità» diventasse un nuovo enorme calderone, una nuova grossa categoria dove porre “i tipi un po’ strani”. Siamo tutti nello stesso grande calderone, tutti persone uniche ma diverse!
Anche ciò che segue, pertanto, è frutto di generalizzazioni! Ogni persona neurodivergente è un universo a sé e non tutte vivono o esprimono questi aspetti allo stesso modo. Lo stesso concetto di neurodiversità nasce per liberare la mente dallo standard, non per creare una nuova macrocategoria rigida. L’intento è spostare il focus dalla “normalizzazione” all’inclusione reale, dove ogni modo di funzionare venga accolto come legittimo, comprensibile e degno.
Non si tratta di “normalizzare il diverso”, ma di riconoscere che ciò che chiamiamo diverso è sempre stato perfettamente normale. Ci è semplicemente sfuggito, perché per troppo tempo abbiamo guardato il mondo con un’unica lente. Questo articolo non vuole classificare, ma aprire spazi di comprensione. Perché la vera normalità è la pluralità.
10 cose che i neurodiversi fanno in modo differente
In questo articolo esploreremo 10 aspetti che le persone neurodivergenti vivono in modo differente, accompagnando ciascun punto con esempi concreti. Come premesso, lo faremo non certo per etichettare ma per comprendere e valorizzare.
1. Pensano per immagini, mappe, pattern o connessioni intuitive
Molte persone neurodiverse – in particolare nello spettro autistico e con dislessia – non usano il linguaggio verbale come canale primario di pensiero. Pensano per immagini mentali, associazioni visive, strutture spaziali o connessioni logiche non lineari. Questo può essere una straordinaria risorsa in ambiti creativi, analitici o strategici.
In psicologia cognitiva, una delle definizioni dell’intelligenza è proprio la capacità di riconoscere pattern: schemi ricorrenti, relazioni non ovvie, connessioni che altri non vedono. E questa è una delle aree in cui le persone neurodiverse eccellono naturalmente. Il pensiero per immagini e pattern non solo rende più ricca l’elaborazione delle informazioni, ma permette anche di risolvere problemi in modo originale e fuori dagli schemi.
Esempio: Anna, con ADHD, durante una riunione affollata di idee confuse, costruisce mentalmente una mappa concettuale visiva, e riesce a proporre una sintesi ordinata che collega i vari elementi come in una rete logica. Il suo cervello lavora per associazioni, non per sequenze. Esatto… nonostante il deficit di attenzione e l’iperattività!
Piccola nota sull’ADHD
Nel cervello umano l’attenzione può assumere due modalità principali:
- Attenzione focalizzata (o convergente): è quella che usiamo quando ci concentriamo intensamente su un compito specifico, escludendo tutto il resto.
- Attenzione diffusa (o divergente): è quella che si attiva quando la mente vaga, collega elementi diversi, lascia spazio all’intuizione e all’associazione libera.
Nel caso dell’ADHD, queste due modalità si alternano in modo imprevedibile. La persona può sembrare distratta o disorganizzata in certi momenti (attenzione diffusa), ma in altri entra in iperfocus, una sorta di “trance” concentrativa in cui è capace di un’immersione totale e produttiva.
Anche se spesso è vissuto come un limite, questo passaggio spontaneo tra i due stati può essere un vantaggio in contesti che richiedono creatività, flessibilità mentale e capacità di connettere idee apparentemente lontane.
2. Percepiscono il mondo sensoriale in modo amplificato (o attenuato)
Le persone neurodiverse hanno spesso un sistema sensoriale iper– o ipo–reattivo. Un suono di sottofondo può diventare assordante. Un tessuto sulla pelle può sembrare insopportabile. Oppure, al contrario, può esserci una soglia sensoriale più alta, che rende difficile notare stimoli che altri trovano fastidiosi.
Esempio: Mario, spettro autistico, indossa solo abiti senza etichette interne perché il contatto con certi materiali gli provoca un senso di bruciore.
3. Hanno un rapporto diverso con il tempo e la transizione tra attività
Il tempo può essere percepito come “non lineare”, con difficoltà a stimare le durate o a rispettare orari. Questo può creare ansia, affaticamento o frustrazione nei contesti scolastici e lavorativi in cui le scadenze e i ritmi sono tutto.
Esempio. Andrea, impiega 30 minuti solo per iniziare i compiti: non riesce a passare dallo stato di riposo alla concentrazione senza un rituale o un aiuto visivo. Per chi è neurodivergente, il passaggio da un’attività all’altra può essere faticoso.
4. Hanno un’intensità emotiva differente, spesso più profonda, più attenuata o meno regolabile
La regolazione emotiva può essere una delle principali sfide. Alcune persone neurodiverse vivono le emozioni in modo molto intenso, con una soglia bassa di tolleranza alla frustrazione o all’eccitazione. Altre, invece, faticano a riconoscerle e comunicarle (alessitimia). In entrambi i casi, il mondo emotivo ha una dinamica diversa. Ne ho parlato tantissimo nel capitolo quinto del mio libro «il mondo con i tuoi occhi».
In questo contesto, si fa molto forte il bisogno di prevedibilità oppure, quando non è possibile annunciare anticipatamente il programma, diventa importante concedere del tempo per elaborare i cambiamenti.
5. Hanno interessi straordinariamente intensi
Molti neurodivergenti sviluppano interessi specifici che coltivano con estrema dedizione. Questi interessi non sono semplici hobby, ma vere e proprie fonti di senso, rifugio e competenza. La società, però, tende a svalutarli se non rientrano in categorie “utili” o socialmente accettate. È davvero buffo perché la stessa società tollera, anzi, accetta perfettamente una persona che basa tutta la sua identità sulla genitorialità (sull’essere mamma o papà), sullo status coniugale (essere moglie, compagno, marito…); accetta anche chi basa la sua identità sulla sua professione…. ma fa fatica quando una persona si identifica con una sua passione!
Esempio: Tommaso, 14 anni, sa tutto sulla città di Tokyo, conosce a memoria anche le fermate delle principali metropolitane e l’intervallo di tempo che occorre per coprire una tratta. Da genitori e coetanei è considerato “ossessionato”, tuttavia con questa sua passione ha rinforzato competenze mnemoniche e logistiche fuori dal comune.
6. Fanno più fatica nei contesti sociali, ma non per “mancanza di empatia”
Una delle idee più sbagliate è che le persone neurodiverse non provino empatia. In realtà, provano empatia profonda ma spesso non riconoscono i segnali sociali impliciti, le convenzioni non dette, i doppi sensi. Questo può causare isolamento o fraintendimenti.
Esempio: Anna è stata esclusa da una festa perché non ha risposto con entusiasmo all’invito. In realtà era felice, ma non lo ha mostrato secondo i codici sociali attesi.
7. Non colgono sfumature nel linguaggio
Un’altra caratteristica comune nelle persone neurodivergenti, in particolare in quelle nello spettro autistico, è la difficoltà nel cogliere il linguaggio figurato, implicito o ambiguo. Questo tipo di comunicazione – fatta di metafore, modi di dire, ironia, sottintesi – può risultare difficile da interpretare perché non ha un significato diretto e univoco.
Chi ha una mente neurodivergente tende a prendere le parole alla lettera. Per questo, frasi che per i neurotipici sono chiare, possono essere confuse o fuorvianti per chi non ha una mente abituata a “decodificare” tra le righe.
Questa difficoltà non è un limite cognitivo. Al contrario, nasce da un processo comunicativo trasparente e logico: per molte persone neurodiverse, le parole hanno un peso e un significato preciso, e non vengono utilizzate per dire il contrario di ciò che si intende (come avviene spesso nel sarcasmo o nell’ironia).
Esempio: Anna, spettro autistico, interpreta il linguaggio in modo molto letterale. Quando sua madre dice: “Dobbiamo andare a fare la spesa”, anche se lo dice in modo astratto o riferito al futuro, lei si alza subito, indossa il giubbotto e si prepara a uscire. Per lei, ciò che si dice è reale e immediato. Le frasi simboliche o metaforiche la mettono in difficoltà, perché non riesce a capire che non vanno prese “alla lettera”.
Questa caratteristica può causare fraintendimenti, frustrazioni o giudizi ingiusti (“non capisce”, “non ascolta”), quando in realtà la persona sta solo seguendo fedelmente il significato letterale di ciò che è stato detto. Con un po’ di adattamento e chiarezza comunicativa, questi ostacoli si possono superare, aprendo a un dialogo autentico e rispettoso. Il problema è che se fin da piccola Anna è stata tacciata come quella che “non ascolta” o “non capisce”, questo modellamento sociale creerà “profezie che si autoavverano” così come spiegato fedelmente nel mio libro «il Mondo con i Tuoi Occhi».
8. Gestiscono l’attenzione in modo non lineare (iperfocus o dispersione)
Come già premesso, nel neurodivergente, l’attenzione è spesso fluttuante e imprevedibile. L’ADHD ne è l’esempio più noto: la mente può saltare da un pensiero all’altro, oppure incollarsi su un’unica attività per ore (iperfocus), ignorando tutto il resto, anche i bisogni fisiologici.
Esempio: Anna trascorre otto ore consecutive a sviluppare il codice informatico del suo nuovo sito, in silenzio assoluto. Il giorno dopo, non riesce a seguire ciò che le viene detto.
9. Riescono a vedere dettagli che sfuggono alla maggior parte delle persone
Una delle forze più straordinarie della neurodivergenza è l’attenzione al particolare. Dove altri vedono un insieme generico, una persona neurodivergente può notare un errore, una connessione inedita, una piccola variazione. Questo talento può essere prezioso nei lavori che richiedono precisione o innovazione.
Esempio: Anna, dislessica e disortografica, nota un errore nella logica narrativa di una sceneggiatura… per fortuna, lo fa ancora prima che venga girata salvando la produzione da una gaffe milionaria!
10. Aderenza radicale
Molte persone neurodivergenti hanno un forte senso di giustizia, che non viene mediato da convenienze sociali. Questo può portare a conflitti soprattutto in contesti gerarchici o in ambienti dove la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa è minima. La loro “intransigenza” non è un’espressione di integrità ma un modo di essere. Questo li rende molto vulnerabili, soprattutto nei contesti sociali o lavorativi dove prevalgono dinamiche opache, compromessi o retorica relazionale.
Esempio: Tommaso ascolta Tizio dire che Moreno è un fannullone. Tommaso, che pensa in modo lineare e coerente, presume che Tizio dirà la stessa cosa anche a Moreno, o che quantomeno glielo abbia già detto in passato. Quando scopre che Tizio ha parlato solo alle spalle e anzi, pubblicamente afferma che Moreno è fantastico, resta sconvolto. Non riesce a concepire una comunicazione bifronte, dove si dice una cosa a qualcuno e il contrario a qualcun altro.
Ecco perché dove esistono gerarchie (soprattutto se informali) e doppi registri comunicativi, queste persone possono sentirsi escluse o provocare reazioni ostili. Non riescono a “gestire le apparenze” perché per loro la coerenza tra interno ed esterno è basilare.
Accogliere le neurodiversità significa ripensare a se stessi e alla società tutta
Accogliere la neurodiversità significa imparare a riconcepire la scuola, il lavoro e la società! Significa non chiedere l’adattamento forzato a un modello unico e tipico ma creare ambienti flessibili dove ogni mente possa esprimersi. Significa, infine, riscoprire che la normalità non è uno standard, ma una convenzione statistica.
Se desideri approfondire il legame tra cervello, emozioni e autenticità, il mio libro «il mondo con i tuoi occhi» (disponibile a questa pagina amazon e in tutte le librerie), può accompagnarti in un viaggio per liberarti dai costrutti che soffocano la tua unicità. Perché ognuno di noi è diverso, meritevole e degno di affermare la propria identità.
Autore: Anna De Simone, psicologo esperto in psicobiologia
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi su Instagram: @annadesimonepsi
Seguire le pagine ufficiali di Psicoadvisor su Facebook: sulla fb.com/Psicoadvisor e su Instagram @Psicoadvisor
