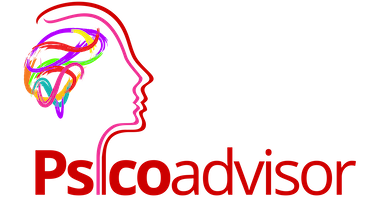La tua mente conserva il ricordo delle parole che ti hanno gratificato e delle critiche che ti hanno ferito, delle situazioni che hai vissuto, delle volte in cui, nonostante gli ostacoli, hai agito e di quelle in cui la paura di fallire ti ha paralizzato. Tiene traccia delle decisioni che hai preso, dei tuoi successi e sconfitte. Il tuo sé attinge da queste memorie.
Il sé, il tuo senso di identità, è una sorta di “contenitore” di autodescrizioni: fisiche, psicologiche, biografiche, relazionali, sociali e si basa, per lo più, su convinzioni e su modi di sentire. In definitiva, non è ciò che davvero sei, ma piuttosto è frutto di come sei abituato a pensare a te stesso.
Possedere un sé stabile è tranquillizzante, ci fa sentire individui con una continuità nel tempo. Ma ha un prezzo: richiede coerenza, cioè che agiamo, nel presente, in modo simile a come abbiamo fatto in passato. Per questa ragione ricerchiamo esperienze a noi familiari e siamo avversi ai nuovi modi di pensare. Così, però, finiamo chiusi in una visione limitata di noi stessi e del mondo.
Come in un circolo vizioso, il nostro sé ci spinge ad agire in modi che lo confermano. Condizionando le nostre azioni, fa sì che il presente non sia libero da influenze. Impedisce al passato di passare. Ecco perché chi ha bassa autostima sembra incapace di accettare i complimenti e di riconoscersi i meriti, anche quelli indiscutibili. Ecco perché cambiare è così difficile
Prendiamo l’esempio di quattro individui
Il primo si sente terribilmente inadeguato
Nel suo continuo paragonarsi ad amici e colleghi, li vede tutti più risoluti di lui. Questo gli fa credere di essere inferiore, di non poter essere capito, né aiutato: “Le persone, in fin dei conti, sono indifferenti”. Ne è convinto, pur riconoscendo che questo suo pessimismo non è un toccasana per ritrovare le forze.
Il secondo passa le giornate nel prefigurarsi sventure che, puntualmente, non si realizzano.
Vive nella paura che la sua attività fallisca, accumula denaro per calmare il timore di non averne abbastanza, si fa prendere dalla gelosia al solo pensiero che la compagna si invaghisca di qualcun altro e lo lasci di punto in bianco. Sa che la sua ansia è dovuta a questo modo di ragionare, ma crede che non riuscirebbe mai a starsene con le mani in mano, nella beata inconsapevolezza, in attesa che una di queste eventualità si avveri cogliendolo impreparato.
Il terzo ha la cronica sensazione di non avere quello che desidera.
Si è licenziato dal precedente impiego perché poco stimolante e ne ha intrapreso uno che gli permette di fare incontri sempre nuovi. Realizzato quello che considerava il suo sogno, però, dopo un’in iziale euforia ha ricominciato a essere scontento: ora è spesso fuori città, sballottato da un aeroporto all’altro, non ha più tempo per coltivare una relazione stabile, ha perso di vista il suo giro d’amicizie, è solo. Eppure è strano, la routine di una vita ordinaria gli sembrava talmente soffocante…
Il quarto ha standard elevatissimi.
Nella professione, come nel quotidiano, punta a prestazioni di livello. In fondo, considera giusto un unico modo di fare le cose, il suo. Collaborare e delegare è una tortura, il suo occhio critico si accorge del più piccolo errore o imprecisione nell’operato dei colleghi.
Così, finisce per assumersi la maggior parte del carico di lavoro o per rifare daccapo compiti già terminati: “Chi fa da sé, fa per tre”. Il risultato? Il ritardo sistematico nell’onorare gli impegni presi e uno stress pressoché continuo.
Tutte queste persone soffrono per via del loro atteggiamento.
La prima, a causa dell’autocritica e della sfiducia, la seconda perché considera il futuro un problema da risolvere, la terza per l’abitudine a svalorizzare quello che ha e a idealizzare ciò che le manca, la quarta per il suo rigido perfezionismo. Ma sembrano indisponibili a rivedere le loro certezze. Qual è il motivo?
Il sé è contrario al cambiamento, vi si oppone. Cambiare significa sempre, almeno un po’, agirvi contro: è una sorta di salto nel buio perché richiede di abbandonare certezze consolidate in anni di azioni e pensieri abitudinari, di accettare di perdere quella parte di noi alla quale, per quanto sia fonte di sofferenza, siamo aggrappati con tutte le forze.
Presuppone, insomma, la disponibilità a rinunciare alla protezione rassicurante di un certo modo di pensare. Cosa non semplice, perfino quando ci è evidente che sono proprio le nostre convinzioni le principali responsabili di come ci sentiamo.
Le motivazioni al cambiamento: quelle che durano e quelle che, invece, sono solo momentanee
Cosa deve accadere perché un ludopatico decida di stare lontano dalle slot? Accumulare debiti tanto grandi da non riuscire più a trovare creditori? A volte sì, ed è per questo che, appena racimolato qualche spicciolo, il problema ricomincia.
Quando una ragazza anoressica abbandona il suo insano controllo alimentare? Nessun ricovero in clinica, nemmeno se centra l’obiettivo di ristabilire un peso normale, garantisce che la paziente metterà davvero in discussione l’ossessiva autosvalutazione che l’ha portata fin quasi a morire.
Aspettarsi che qualcuno cambi solo perché glielo chiediamo, perché ci sembra giusto o doveroso o perché gli abbiamo dimostrato con argomenti fondati quali vantaggi ne otterrebbe, è pura fantasia. Lo sanno bene i parenti dei giocatori d’azzardo e di chi ha disturbi alimentari. Ma anche chi reclama dal partner un maggiore coinvolgimento nella relazione o quei genitori che cercano, invano, di persuadere i figli dell’importanza dell’impegno nello studio.
Azioni spinte dall’ansia, dal senso di colpa, dalla paura dell’abbandono e del fallimento, quasi mai generano un vero cambiamento; al massimo una fuggevole imitazione. Un cambiamento che si basa su queste motivazioni, infatti, come compare, svanisce, una volta riassorbite le emozioni che lo avevano indotto. Per questa ragione, spesso, coniugi e genitori frustrati, sbottano: “Dovrei minacciarlo ogni giorno perché si comporti come dovrebbe”.
Cambiare è possibile
Come esseri umani possiamo farlo a qualsiasi età. Ma un cambiamento autentico è lento, si consolida solo con l’esercizio di comportamenti e pensieri nuovi, alternativi ai precedenti; è frutto di una scelta che, anche se può essere influenzata dall’esterno, deve essere presa in modo spontaneo.
E, soprattutto, è basato su valori e non su emozioni o sentimenti passeggeri. Solo ciò in cui si crede fino in fondo può motivare a impegnarsi a sovvertire schemi vecchi di decenni. Possiamo cambiare solo quando prendiamo consapevolezza del fatto che il nostro modo di essere o di fare contrasta con qualcosa che vogliamo fortemente.
I tre “ingredienti” senza i quali il cambiamento è impossibile… e che dovrebbero essere l’obiettivo di ogni buona psicoterapia
Il primo requisito per un vero cambiamento è la presenza di valori e obiettivi, senza i quali il comportamento non può avere una precisa direzione. Valori e obiettivi sono, per definizione, qualcosa a cui l’individuo attribuisce importanza, ma non sono sinonimi. Verso un valore si può solo tendere, un obiettivo è una meta raggiungibile.
Avere figli, laurearsi o diventare medico sono obiettivi, essere genitori o professionisti attenti e capaci è un valore. Una seria intenzione al cambiamento presuppone sempre, come tappe intermedie, obiettivi realizzabili e come direzione uno o più valori. Di nuovo, torna centrale l’aspetto della presa di responsabilità: valori e obiettivi possono essere, sì, incoraggiati, ma non indotti dall’esterno. Al contrario, vanno “costruiti” in modo consapevole e deliberato.
Il secondo requisito consiste nella capacità di prevedere le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni, di non reiterare le vecchie abitudini. In una parola, un cambiamento per compiersi richiede autocontrollo. L’impulsività è la tendenza ad agire di getto senza considerare che i risultati attesi, in tal modo, potrebbero non verificarsi; è difficile che una persona sprovvista di un minimo di autocontrollo possa tenere a bada quella parte di sé che la spinge verso i soliti comportamenti.
Terzo e ultimo requisito è la flessibilità. La flessibilità comportamentale è la capacità di adattare le azioni alle circostanze e alle esigenze ambientali: di astenersi dall’agire quando le condizioni esterne non lo consentono e di attivarsi, invece, quando ciò è possibile. Per flessibilità cognitiva, invece, si intende la capacità di accettare anche quelle condizioni che sono diverse da come le si vorrebbe, di modificare i propri pensieri in funzione della realtà e di assumere la prospettiva di chi ha idee diverse.
A cura di Gabriele Calderone, psicologo psicoterapeuta. Riceve su appuntamento nei suoi studi di Parma e Reggio Emilia. Info 389 0468477 – 340 9925256.
Se ti piacciono i nostri contenuti, puoi seguirci sulla pagina Ufficiale Facebook di Psicoadvisor e sul nostro account Instagram: @Psicoadvisor