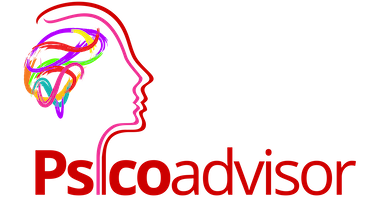Ma cambiare non è una questione di forza di volontà
Non è una mancanza di carattere, né un difetto personale. Cambiare è, innanzitutto, un’impresa biologica, emotiva e affettiva. Restare dove si soffre, per quanto possa sembrarci assurdo, è spesso una strategia di protezione. Non ci rimaniamo perché ci fa bene, ma perché il cervello e il corpo ci trattengono lì, in quello che conoscono, in ciò che è prevedibile. Perché per il nostro sistema nervoso, ciò che è noto è automaticamente interpretato come più sicuro di ciò che è nuovo.
E allora, prima di condannarci per le volte in cui non riusciamo a cambiare, forse dovremmo imparare ad ascoltare cosa sta davvero accadendo dentro di noi. Perché quel “restare” non è un fallimento, ma un messaggio. È un codice che, se impariamo a decifrare, può diventare il primo passo verso una trasformazione autentica.
Il cervello non vuole renderci felici. Vuole mantenerci vivi.
Il nostro cervello è un geniale sistema di protezione. Ma, contrariamente a quanto potremmo pensare, non è progettato per farci stare bene. È progettato per farci sopravvivere. E per sopravvivere, deve poter prevedere. Deve sapere cosa aspettarsi. Così, anche quando ci troviamo in una relazione che ci spegne o in un’abitudine che ci svuota, il cervello, se la riconosce come familiare, la sceglie comunque. Per lui è più importante la prevedibilità che il benessere. L’incognita del cambiamento, anche se portatrice di possibilità, viene letta come una minaccia. E ogni volta che tentiamo di modificare qualcosa di profondo nella nostra vita, il sistema limbico — in particolare l’amigdala, la sentinella delle minacce — si attiva. Non distingue se quel “nuovo” è positivo o negativo, sa solo che è diverso. E diverso, per il nostro cervello emotivo, equivale a potenzialmente pericoloso.
Così il corpo entra in allerta: il cuore accelera, la tensione muscolare cresce, il respiro si accorcia. Si attiva quella che in biologia chiamiamo risposta “fight or flight”, lotta o fuga. Ma se non possiamo né combattere né scappare, l’energia resta intrappolata. E tutto il sistema va in tilt.
Il piacere del noto: una gratificazione chimica
C’è anche un altro meccanismo, meno evidente ma potentissimo, che ci tiene agganciati a ciò che ci fa male: il circuito della dopamina. Ogni volta che ripetiamo un comportamento abituale, anche se disfunzionale, il cervello rilascia una piccola dose di dopamina. Non perché stiamo facendo qualcosa di giusto o benefico, ma semplicemente perché stiamo facendo qualcosa che conosce. Questo genera una sorta di dipendenza dalla ripetizione. Il familiare diventa gratificante proprio in quanto prevedibile. In pratica, il nostro sistema di ricompensa premia l’abitudine, anche quando ci logora. È così che restiamo in relazioni tossiche, ruoli soffocanti, schemi che ci auto-sabotano: perché ogni ritorno al “copione noto” viene silenziosamente registrato come “successo”. Non perché ci fa bene, ma perché ci dà la sensazione — biologica — di essere in controllo.
Il corpo sotto stress: un sistema nervoso sempre in allerta
Quando il nostro sistema nervoso resta iperattivato per lunghi periodi, entriamo in uno stato di stress cronico. Non si tratta di ansia passeggera, ma di una tensione di fondo che si radica nel corpo. Il battito è costantemente accelerato, le mani sudano, il sonno si fa leggero o frammentato, la digestione si blocca, la mente fatica a rallentare. Questi segnali non sono malfunzionamenti. Sono espressioni di un sistema che cerca disperatamente di regolare una minaccia che percepisce ma non riesce a risolvere. E la minaccia non è fuori, è dentro. È quel conflitto continuo tra ciò che vorremmo cambiare e ciò che temiamo di perdere. Il corpo si blocca, perché sa che cambiare significa rompere un equilibrio. Anche se quell’equilibrio ci sta consumando.
Le origini affettive del restare: imparare a non disturbare
Per capire fino in fondo perché restiamo, dobbiamo andare alle radici della nostra storia. Da piccoli, impariamo a leggere il mondo emotivo degli altri prima ancora di conoscere il nostro. Se abbiamo percepito che esprimere rabbia, tristezza, disagio o bisogno portava distacco, silenzio, giudizio o punizione, abbiamo imparato a trattenerci. Abbiamo capito che per essere amati dovevamo adattarci, e che l’amore andava meritato, non ricevuto gratuitamente. Queste esperienze precoci diventano i mattoni su cui costruiamo la nostra identità. E anche da adulti, finiamo per restare nei ruoli che un tempo ci hanno fatto sentire al sicuro, anche se oggi ci fanno male. Restiamo perché è lì che ci siamo sentiti visti, riconosciuti, almeno una volta. E tradire quei ruoli ci fa paura. Non perché siamo fragili, ma perché sentiamo che stiamo abbandonando qualcosa che, per un tempo, ci ha salvato.
Fedeltà invisibili e colpe che non ci appartengono
Cambiare significa spesso rompere legami interiori invisibili. Sono le fedeltà silenziose a un’idea di noi stessi, a un modello familiare, a un copione emotivo. Sono promesse antiche fatte senza parole, ma incise dentro: “Non sarò mai un peso”, “Non farò soffrire nessuno”, “Mi accontenterò”. Infrangere queste promesse, anche solo spostandoci di un millimetro da ciò che ci è stato insegnato, può generare un senso di colpa profondo. Ci sentiamo egoisti, ingrati, inadeguati. E così restiamo. Non perché non vogliamo cambiare, ma perché ci sembra che, per cambiare, dovremmo smettere di essere “quelli che sono sempre stati bravi”. Ma la verità è che non siamo obbligati a rimanere fedeli a ciò che ci fa male. Possiamo restare fedeli a noi stessi, anche se questo significa deludere aspettative vecchie di decenni.
Cambiare è possibile, ma non forzando
Il primo passo per cambiare non è forzarsi a fare qualcosa di diverso. È iniziare a creare uno spazio interno in cui sentirsi al sicuro. Solo quando il sistema nervoso percepisce che non siamo in pericolo, può abbassare la soglia di allerta e permetterci di agire in modo nuovo. Questo può accadere attraverso piccoli gesti di ascolto: un confine messo, un “no” detto con gentilezza, un bisogno riconosciuto. Oppure attraverso esperienze di cura: una relazione terapeutica che ci accoglie, una pratica corporea che ci riconnette, uno spazio in cui non serve lottare per esistere. Il cambiamento è possibile. Ma non nasce dalla spinta. Nasce dal contatto con sé.
Quando smetti di trattenerti, inizi a fiorire
Restare dove soffri non è un difetto. È un adattamento. È il modo in cui il tuo corpo e la tua mente hanno cercato di proteggerti. Ma ora che sai, puoi anche scegliere. Puoi insegnare al tuo sistema nervoso che non tutto ciò che è nuovo è pericoloso, e che non devi più sacrificarti per meritare amore. Puoi fiorire, anche se tremi. Anche se non sai da dove cominciare. Perché non c’è un tempo giusto per cambiare, ma c’è un tempo in cui smetti di tradirti. E quello, quando arriva, non si dimentica più.
Nel mio libro Il mondo con i tuoi occhi, racconto proprio questo viaggio: la trasformazione profonda che accade quando iniziamo a guardare la nostra storia senza giudizio, ma con verità. Quando smettiamo di restare per paura e iniziamo a costruire la vita che ci somiglia davvero. Non quella che ci è stata insegnata, ma quella che possiamo finalmente scegliere. Per immergerti nella lettura e farne tesoro, puoi ordinarlo qui su Amazon oppure in qualsiasi libreria
A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoasvisor
Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.