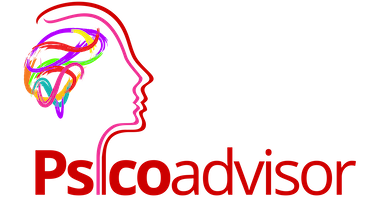In chi adotta questa postura psichica in modo costante, il senso di offesa e d’ingiustizia diventa parte integrante del modo di interpretare la realtà, se stessi e gli altri. Tutto viene filtrato attraverso la lente della colpa altrui e della propria innocenza sofferente. Ma cosa si nasconde dietro questo atteggiamento? Perché alcune persone sembrano vivere sempre all’ombra di un torto subito, reale o immaginato?
In questo articolo ci addentreremo nella struttura psicologica del vittimismo cronico, riconosceremo i segnali che lo rivelano, analizzeremo le cause più profonde e le ricadute che ha nelle relazioni, sia per chi lo mette in atto, sia per chi lo subisce.
I segnali tipici del vittimista
Ci sono parole, atteggiamenti e posture relazionali che, a lungo andare, rivelano una modalità ricorrente di vivere il mondo in funzione di una sofferenza autoalimentata. Ecco alcuni segnali ricorrenti:
- Tendenza a colpevolizzare gli altri: ogni disagio, difficoltà o frustrazione viene attribuito a cause esterne. Nulla è mai responsabilità propria, nemmeno in parte.
- Lamentela cronica: una narrazione pervasiva di ingiustizie subite, accompagnata da frasi come “a me capitano tutte”, “nessuno mi capisce”, “sono sempre l’unico/a che…”.
- Rifiuto del confronto autentico: chi si sente vittima non desidera una vera riparazione, ma piuttosto essere confermato nel proprio dolore. Qualunque tentativo di invitare alla riflessione viene percepito come un attacco.
- Difficoltà a provare empatia: paradossalmente, chi vive nel ruolo della vittima tende a non vedere la sofferenza altrui, troppo assorbito dalla propria. L’attenzione è costantemente centrata sul proprio vissuto.
- Uso del ricatto emotivo: il dolore viene trasformato in leva per ottenere attenzioni, conferme o senso di potere relazionale. A volte, anche inconsciamente, si usano frasi come “dopo tutto quello che ho fatto per te…” o “mi hai fatto star male e neanche te ne rendi conto”.
Le radici psicologiche: quando il dolore diventa identità
Dietro il vittimismo cronico si nasconde quasi sempre un dolore antico. Spesso, chi oggi si rifugia nel ruolo della vittima, da piccolo è stato realmente vittima. Vittima di trascuratezza emotiva, di genitori ipercritici, di un ambiente familiare dove esprimere bisogni e disagi era proibito o punito.
Il bambino che non ha potuto dire “mi fa male” o “ho bisogno di te” in modo diretto e accolto, impara presto che la sofferenza può essere l’unico modo per ottenere attenzione, tenerezza, ascolto. Con il tempo, questo meccanismo può strutturarsi come una vera e propria forma identitaria: “se sto male, allora valgo”.
Questo fenomeno ha una base neurobiologica. Il cervello impara per associazioni: se il dolore emotivo genera una risposta (carezze, vicinanza, ascolto), il sistema limbico registra questa connessione. È un apprendimento implicito che si radica in strutture profonde come l’amigdala e l’insula, coinvolte nella codifica delle emozioni e del dolore sociale.
Col tempo, però, il circuito si cristallizza: il dolore non è più solo un’esperienza da attraversare, ma diventa uno stato da mantenere per sentirsi visti.
Il ruolo della formazione reattiva: la rabbia che non si può mostrare
Un altro meccanismo inconscio che contribuisce alla formazione del vittimismo è la formazione reattiva. Chi si sente sempre vittima, spesso ha represso per anni una rabbia intensa verso le figure primarie. Ma non potendo esprimerla (per paura di perdere amore o protezione), quella rabbia viene trasformata nel suo opposto: nella passività sofferente.
La vittima cronica non si arrabbia mai in modo diretto, ma fa sì che siano gli altri a sentirsi colpevoli. È una rabbia che agisce per interposta persona, mascherata sotto forma di pianto, silenzi, malesseri vaghi, ritiro o frasi passive-aggressive.
Nel linguaggio psicoanalitico si tratta di un conflitto tra il desiderio di affermarsi e la paura della punizione affettiva. Meglio apparire deboli che rischiare il rifiuto. Ma a lungo andare, questo meccanismo impoverisce ogni forma di autenticità.
Le conseguenze nelle relazioni affettive
Una persona che si percepisce sempre vittima vive relazioni profondamente sbilanciate. All’inizio può apparire fragile e bisognosa di cure, suscitando empatia e desiderio di protezione. Ma col tempo, il copione relazionale si fa più tossico. Ecco alcune conseguenze tipiche:
Ruoli fissi e inamovibili: chi vive da vittima cerca inevitabilmente qualcuno che faccia da “carnefice” o da “salvatore”. Si attivano dinamiche triangolari che impediscono un confronto paritario.
- Erosione della complicità: in coppia, la lamentela cronica spegne il desiderio e il senso di progettualità. Ogni discussione diventa un tribunale dove l’altro è sempre imputato.
- Colpa indotta nell’altro: il partner può sentirsi continuamente in difetto, sotto esame, incapace di riparare un danno mai chiarito. Questo genera frustrazione, senso di inadeguatezza e, spesso, allontanamento.
- Impossibilità di crescere insieme: la vittima cronica non è interessata alla trasformazione della relazione, ma alla conferma del proprio stato emotivo. Qualsiasi cambiamento viene vissuto come una minaccia alla propria identità sofferente.
Vittimismo e dipendenza affettiva: due volti della stessa ferita
In molti casi, il vittimismo si intreccia con la dipendenza affettiva. Chi vive costantemente nel ruolo della vittima, ha bisogno dell’altro non solo per sentirsi amato, ma anche per mantenere in vita la propria narrazione interiore. Se nessuno ascolta il tuo dolore, quel dolore sembra smettere di esistere — e con esso, anche la tua identità.
Il legame diventa allora una scena teatrale in cui si recita sempre lo stesso copione: tu soffri, l’altro non capisce, tu ti ritiri, l’altro si colpevolizza o si arrabbia. È un circuito chiuso che blocca qualunque possibilità di evoluzione.
In neurobiologia, si può osservare che le aree cerebrali coinvolte nella percezione del dolore sociale (in particolare la corteccia cingolata anteriore) si attivano con la stessa intensità di un dolore fisico reale. Questo spiega perché chi si sente sempre vittima vive le relazioni con un’intensità emotiva così alta, ma anche così fragile.
Come si esce dal ruolo della vittima
Uscire da questa posizione psicologica non significa sminuire il proprio dolore, né vergognarsi di aver sofferto. Significa, piuttosto, riappropriarsi della propria responsabilità emotiva. Ecco alcuni passaggi fondamentali:
- Riconoscere il copione: ammettere a sé stessi che si tende a interpretare le situazioni attraverso una lente di sofferenza passiva. Questo non è un atto di accusa, ma il primo passo per il cambiamento.
- Dare un nome alla rabbia: molte vittime croniche sono persone che non si sono mai concesse il diritto di arrabbiarsi. Riconoscere la propria rabbia come legittima è uno snodo terapeutico centrale.
- Imparare a comunicare in modo assertivo: invece di dire “mi hai fatto stare male”, si può imparare a dire “quando succede questo, io mi sento così, e ho bisogno di…”. È una piccola rivoluzione che riporta potere e responsabilità dentro di sé.
- Coltivare un’identità alternativa: è possibile stare al mondo anche senza essere definiti dal dolore. La sofferenza vissuta può trasformarsi in comprensione profonda, empatia autentica, capacità di contenere anche la fragilità altrui — senza più usarla come arma.
Il diritto di esistere anche senza dolore
Non è facile ammettere di aver usato la sofferenza come strumento per essere visti, amati, riconosciuti. Ma è un atto di coraggio straordinario. Significa rientrare in possesso di sé stessi, smettere di elemosinare conferme attraverso la lamentela e iniziare a costruire relazioni più vere, più libere, più nutrienti.
Chi si sente sempre vittima non è una persona cattiva, né manipolatrice per natura. È spesso un’anima che ha imparato, troppo presto, che per essere amati bisogna soffrire. Ma oggi, da adulti, possiamo riscrivere quel messaggio. Possiamo imparare che meritiamo amore anche quando siamo forti, anche quando siamo sereni, anche quando non abbiamo nulla da raccontare se non la pace che finalmente sentiamo.
Nel mio libro Il mondo con i tuoi occhi, ho dedicato molte pagine a questi temi. Non per giudicare o classificare, ma per offrire strumenti concreti e profondi a chi vuole smettere di vivere nel dolore per iniziare, finalmente, a vivere nella libertà. La libertà di essere visti, compresi e accolti… senza più dover soffrire per forza. Il mio libro è disponibile in libreria e qui su Amazon
E se ti va, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.
Ti aspetto lì per continuare il viaggio.