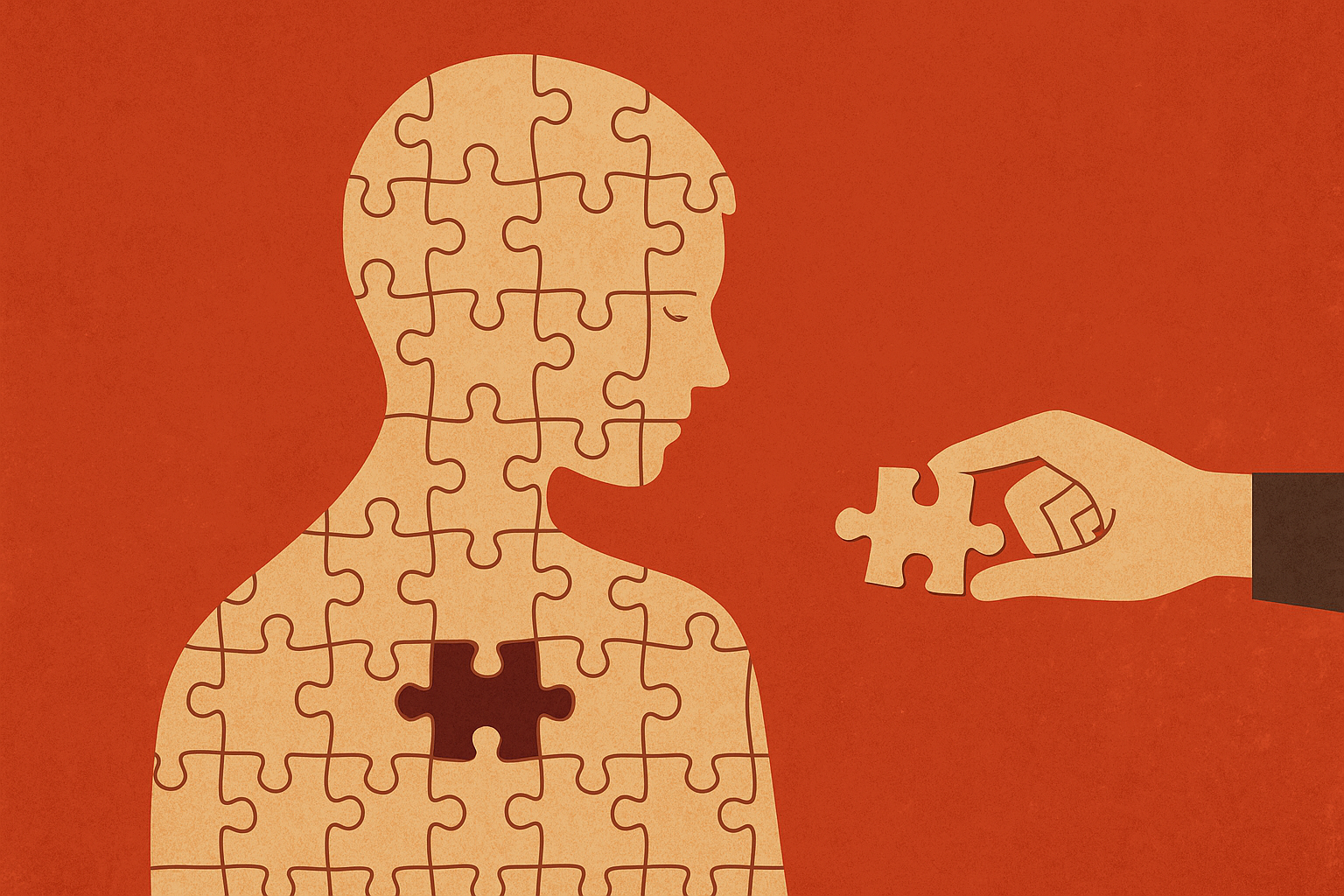 C’è una differenza profonda tra l’altruismo sano e quello che si fa carico del dolore altrui per non vedere il proprio. Tra il gesto generoso e il bisogno compulsivo di essere “quello che aiuta sempre”.
C’è una differenza profonda tra l’altruismo sano e quello che si fa carico del dolore altrui per non vedere il proprio. Tra il gesto generoso e il bisogno compulsivo di essere “quello che aiuta sempre”.
A prima vista, l’altruista estremo è l’amico ideale, il compagno comprensivo, il collega disponibile. È quello che ti ascolta per ore senza mai parlare di sé, che fa il doppio del necessario, che anticipa ogni tuo bisogno. Eppure, qualcosa in lui — o in lei — a un certo punto si incrina: un senso di stanchezza profonda, un accumulo di frustrazione silenziosa, o un improvviso crollo emotivo che nessuno si aspettava.
Cosa si cela dietro il comportamento troppo altruistico
Perché spesso dietro chi dà troppo si nasconde qualcuno che ha imparato a non chiedere mai.
Qualcuno che ha associato il proprio valore alla capacità di essere utile, buono, indispensabile.
E che ha imparato a tenere sotto controllo il proprio mondo interiore attraverso il bisogno degli altri.
In questo articolo esploreremo le radici psichiche e neurobiologiche dell’altruismo eccessivo, mettendo in luce le ferite invisibili, i modelli interiorizzati, e i meccanismi di difesa che lo alimentano.
Perché chi dona troppo, spesso lo fa per paura di guardarsi dentro.
1. Il bisogno di essere amati senza mai chiederlo
Molti altruisti compulsivi hanno avuto un’infanzia in cui l’amore era condizionato al comportamento.
Sono bambini che hanno imparato presto che essere bravi, accondiscendenti, adulti in miniatura, portava approvazione.
Non hanno fatto capricci, non hanno chiesto troppo, si sono adattati ai bisogni dei genitori, talvolta assorbendoli completamente. E così hanno iniziato a credere che il modo migliore per essere amati fosse essere necessari.
Questa logica silenziosa diventa un pilastro identitario: “Se sono utile, allora ho un posto nel cuore dell’altro”.
In realtà, il bisogno d’amore non scompare: viene solo trasformato in una forma di amore performativo, dove il dare diventa l’unico linguaggio affettivo possibile.
Chi ha bisogno, invece, viene inconsciamente svalutato: meglio essere chi sostiene, mai chi crolla.
2. L’altruismo come formazione reattiva: nascondere la rabbia dietro la bontà
In psicoanalisi, una formazione reattiva è un comportamento che maschera l’impulso opposto.
Molti eccessi di altruismo possono essere letti in questa chiave: donare per non sentire il rancore, aiutare per non entrare in contatto con il senso di frustrazione o la rabbia accumulata.
Se non sei stato visto, contenuto, accolto… il tuo dolore può diventare talmente intollerabile da trasformarsi in iper-disponibilità: “Se divento indispensabile, nessuno mi abbandonerà più.”
In questo senso, l’altruismo estremo è una strategia difensiva, più che una vocazione: è un modo per anestetizzare la delusione e mantenere relazioni apparentemente armoniche, evitando lo scontro diretto con la propria vulnerabilità.
3. Il cortocircuito tra empatia e disregolazione affettiva
Dal punto di vista neurobiologico, le persone altamente altruiste mostrano un’attività elevata nella corteccia prefrontale mediale e nelle aree limbiche legate all’empatia, come l’insula e l’amigdala.
Ma l’altruismo eccessivo non è sempre segno di regolazione: in molti casi, al contrario, è segno di una disregolazione emotiva.
La sofferenza dell’altro viene sentita in modo amplificato, come se fosse propria. Questo accade perché il cervello della persona eccessivamente altruista non distingue più bene tra sé e l’altro, fondendosi nell’esperienza empatica fino al punto da cancellare i propri confini emotivi.
Chi ha avuto genitori intrusivi o non differenziati, spesso sviluppa un iper-sistema di attenzione emotiva all’esterno: coglie il disagio degli altri prima ancora che venga espresso, ma fatica a contattare i propri stati interni.
Così, aiutare diventa anche un modo per regolare la propria ansia: l’altro sta meglio → io mi calmo → ho fatto bene.
4. Il bisogno narcisistico di “essere buoni”
Paradossalmente, dietro l’altruismo patologico può esserci anche un nucleo narcisistico: il bisogno di essere riconosciuti come “persone buone”.
La bontà, in questi casi, non è gratuita, anche se chi la esercita lo nega: è una forma di controllo dell’immagine di sé.
Ogni volta che qualcuno dice “sei troppo buono”, la persona altruista eccessiva sente di valere un po’ di più.
Questo meccanismo può diventare talmente automatico da portare a un’identificazione totalizzante col ruolo di “salvatore”. Ma dietro c’è spesso un vuoto identitario, mai nutrito da un amore incondizionato, che spinge a cercare valore nella funzione, e non nell’essere.
5. La paura del rifiuto: se non do, non valgo
Un altro motore profondo dell’altruismo eccessivo è la paura del rifiuto.
Chi ha interiorizzato la convinzione di essere amabile solo in quanto utile, vive ogni gesto di cura come una moneta d’amore. Non può smettere di dare, perché teme che — nel momento in cui si fermasse — l’altro se ne andrebbe.
Questa è la logica della dipendenza relazionale: il dare eccessivo non nasce da libertà, ma da paura dell’abbandono.
E ogni volta che l’altro non ricambia, non comprende, o non accetta l’aiuto… si attiva una ferita antica, quella del bambino che non è stato accolto, nonostante tutti i suoi sforzi.
6. L’identità costruita sul bisogno dell’altro
Molte persone eccessivamente altruiste non sanno chi sono al di fuori del bisogno dell’altro.
La loro identità si regge su frasi interiorizzate come:
- “Se non servo a nulla, allora sono nulla.”
- “Non posso deludere chi conta su di me.”
- “Gli altri vengono prima.”
Ma questa assenza di sé ha un costo altissimo: prima o poi arriva il momento in cui la persona altruista si accorge di essere stanca, sola, o addirittura risentita nei confronti delle stesse persone che ha aiutato.
A quel punto può esplodere un crollo emotivo, o una crisi identitaria: chi sono io, se smetto di salvare gli altri?
7. L’altruismo estremo come autocondanna
Chi non riesce a ricevere — o peggio, si sente in colpa quando lo fa — vive il dare come una forma di espiazione.
Dare, allora, diventa un modo per tenersi lontano da ciò che si desidera davvero.
Un modo per restare “dalla parte giusta”, per non essere vulnerabile, per non sentire il vuoto che emerge quando si chiede e non si ottiene.
Questo altruismo, in apparenza nobile, può diventare una condanna invisibile. La persona altruista non si sente autorizzata a scegliere per sé. Non sa più distinguere tra sacrificio e amore. E, spesso, viene sfruttata o fraintesa, senza mai permettersi di dire “no”.
Come si guarisce: imparare a ricevere, non solo a dare
Il primo passo è riconoscere il proprio bisogno, senza vergogna.
Chi è eccessivamente altruista deve imparare a fare una cosa difficilissima: accettare di essere vulnerabile, bisognoso, e anche un po’ egoista. Non per ferire, ma per esistere.
Guarire da questo schema significa rimettere al centro il proprio spazio interno, imparare a dire no senza sensi di colpa, e ad aiutare senza perdere sé stessi. Significa scegliere di donare non per dovere, ma per amore autentico — che include anche l’amore verso di sé.
Ciò che non ti dai finisci per regalarlo troppo agli altri
Spesso, chi dà troppo agli altri è proprio chi non si è mai sentito abbastanza da ricevere. E allora cerca, attraverso l’altruismo, di ottenere un briciolo di conferma, di essere visto, di sentire che esiste. Ma l’amore che salverà queste persone non sarà mai quello che ricevono dopo aver dato tutto. Sarà quello che impareranno a darsi anche quando non danno nulla.
Perché si può essere buoni senza perdersi. Si può essere generosi senza svuotarsi. E soprattutto, si può essere amati anche senza fare nulla per meritarselo.
Di tutto questo parlo anche nel mio libro Il mondo con i tuoi occhi, dove esploro i meccanismi invisibili che guidano i nostri legami e offro strumenti concreti per costruire un amore che non chiede di sacrificarsi per esistere. Perché guarire, a volte, significa imparare a smettere di salvare tutti… e iniziare finalmente a salvare sé stessi. Il mio libro è disponibile in libreria e qui su Amazon
E se ti va, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.
Ti aspetto lì per continuare il viaggio.
