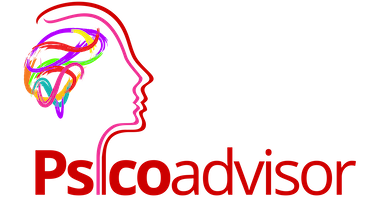Ci sono frasi che sembrano innocue. Le diciamo con leggerezza, senza pensarci troppo, come se fossero il sottofondo automatico della nostra vita. Eppure, quelle stesse frasi raccontano molto più di quanto immaginiamo. Non sono semplici espressioni linguistiche, ma frammenti di una storia affettiva. Sono il linguaggio inconsapevole di ferite antiche, soprattutto di quelle che si formano quando, da piccoli, non siamo stati visti, ascoltati, contenuti.
Ci sono frasi che sembrano innocue. Le diciamo con leggerezza, senza pensarci troppo, come se fossero il sottofondo automatico della nostra vita. Eppure, quelle stesse frasi raccontano molto più di quanto immaginiamo. Non sono semplici espressioni linguistiche, ma frammenti di una storia affettiva. Sono il linguaggio inconsapevole di ferite antiche, soprattutto di quelle che si formano quando, da piccoli, non siamo stati visti, ascoltati, contenuti.
Chi è stato trascurato emotivamente durante l’infanzia spesso non lo sa
Non lo ricorda in modo cosciente. Perché nessuno lo ha picchiato, nessuno lo ha abbandonato fisicamente. Ma mancava qualcosa. Qualcosa di essenziale: lo sguardo che accoglie, la voce che rassicura, il tocco che consola. La presenza emotiva. E allora, quell’assenza si traduce in un linguaggio adulto fatto di auto-svalutazioni, adattamenti, scuse e colpe interiorizzate.
Frasi tipiche di chi è stato trascurato emotivamente durante l’infanzia
In questo articolo esploreremo proprio questo: le frasi tipiche di chi, da bambino, ha imparato a non disturbare, a non chiedere, a non essere un peso. Frasi che raccontano un tentativo costante di esistere senza occupare troppo spazio. Frasi che sono richieste d’amore non dette.
1. “Non è importante”
(Ma in realtà avrebbe voluto che lo fosse, almeno per qualcuno)
Spesso chi è stato trascurato emotivamente minimizza i propri bisogni: “Non è importante”, “Fa niente”, “Lascio stare”. Questo atteggiamento ha radici profonde. È la voce del bambino che ha imparato a non chiedere perché sapeva che nessuno avrebbe risposto. Minimizzare diventa una strategia di sopravvivenza: meglio non aspettarsi nulla che restare delusi.
Dal punto di vista psicoanalitico, siamo di fronte a un meccanismo di difesa: la rimozione del bisogno come tutela contro il dolore del rifiuto. Sul piano neurobiologico, questa dinamica è associata a una cronicizzazione dell’asse dello stress: il cervello del bambino trascurato impara a non attivarsi per la ricerca dell’altro, riducendo la dopamina associata all’attesa relazionale.
2. “Sono io che esagero”
(Ma spera ancora che qualcuno gli dica: “Hai tutto il diritto di sentirti così”)
Chi è cresciuto in un ambiente in cui le emozioni venivano invalidate – “non piangere”, “non fare così”, “non è niente” – finisce per mettere in discussione le proprie reazioni. Ogni volta che sente qualcosa di intenso, si autoaccusa: “Sono io che sono troppo sensibile”, “Forse sto esagerando”.
È il risultato di un attaccamento insicuro di tipo evitante o disorganizzato, in cui il bambino interiorizza l’idea che ciò che sente sia sbagliato o eccessivo. Dal punto di vista neuroscientifico, questa invalidazione precoce compromette il funzionamento della corteccia prefrontale nella regolazione affettiva, lasciando spazio a una mente che si disconnette da sé stessa.
3. “Non voglio dare fastidio”
(Ma sogna di essere accolto anche solo per quello che è)
Questa frase è il simbolo di chi, fin da piccolo, ha imparato che i propri bisogni non solo non erano accolti, ma erano addirittura un intralcio. Spesso sono bambini cresciuti con genitori emotivamente assenti, depressi o centrati su sé stessi. In quelle dinamiche, il figlio si adatta, diventando silenzioso, invisibile, “bravo”.
In età adulta, questo si traduce in una modalità relazionale iperadattiva: si antepongono sempre i bisogni degli altri, si evita ogni forma di conflitto, si chiede il minimo indispensabile. È la “gentilezza patologica” descritta anche in ambito clinico, in cui l’individuo sacrifica il proprio sé per garantirsi l’accettazione.
4. “Va tutto bene”
(Ma dentro c’è un caos che non sa più come nominare)
“Va tutto bene” è la bugia automatica di chi ha imparato a non mostrarsi fragile. È la frase di chi, nell’infanzia, non ha potuto permettersi di crollare, perché sapeva che nessuno lo avrebbe raccolto. È l’eco di un’infanzia emotivamente desertificata, in cui il dolore veniva ignorato o ridicolizzato.
Sul piano psicoanalitico, questa frase è una difesa contro il sentimento di impotenza. Nasconde una dissociazione tra ciò che si prova e ciò che si comunica. E, dal punto di vista biologico, può diventare una vera anestesia emotiva: uno stato di disconnessione limbica in cui le emozioni vengono “spente” per non sentire il vuoto.
5. “Tanto non cambierà nulla”
(Ma dentro ha una piccola voce che vorrebbe crederci ancora)
La rassegnazione è spesso un lascito dell’infanzia trascurata. Quando il bambino ha fatto mille tentativi per essere visto – con i voti, con la malattia, con il silenzio, con la rabbia – e ha ricevuto solo indifferenza, allora smette di sperare. Il “tanto non serve” diventa il nuovo mantra.
Questo fatalismo appreso può avere effetti devastanti sull’autoefficacia e sulla motivazione. È ciò che Seligman definì “impotenza appresa”: uno stato psicologico in cui l’individuo rinuncia all’azione perché ha interiorizzato che nulla dipende da lui. Un circuito cerebrale depotenziato nelle sue funzioni dopaminergiche, che traduce il passato nel presente.
6. “Scusa se parlo troppo” / “Scusa se ti disturbo”
(Ma desidera con tutto il cuore essere ascoltato senza sentirsi di troppo)
Chi è stato trascurato tende a percepire sé stesso come una presenza “di troppo”. Anche un semplice messaggio può sembrare una violazione dello spazio altrui. Ogni volta che si esprime qualcosa, parte un bisogno di scusarsi, come se si stesse abusando di una libertà.
Questo atteggiamento non è altro che il riflesso di un attaccamento ambivalente: “Mi ami solo se non ti peso”. Il bambino diventa ipervigile, sempre attento a non superare il limite, sempre pronto a “non chiedere troppo”. E questa tensione si mantiene nella vita adulta, diventando un perenne autocontrollo relazionale.
7. “Ce la faccio da solo”
(Ma dentro spera che qualcuno se ne accorga, finalmente)
L’autosufficienza estrema non è sempre un segno di forza. Spesso è una ferita che si camuffa da indipendenza. Chi è stato trascurato ha imparato a non contare su nessuno. E così cresce con la convinzione che sia meglio cavarsela da soli, che affidarsi sia un rischio troppo alto.
Ma questa frase ha un sottofondo malinconico: la speranza segreta che qualcuno, prima o poi, riconosca la fatica e offra aiuto. È un bisogno di accudimento congelato, ma mai del tutto scomparso. Nei circuiti cerebrali si traduce in un’anomala coesistenza tra iperattivazione dell’amigdala e inibizione dei circuiti sociali dell’accudimento.
8. “Sono fatto così”
(Ma in realtà vorrebbe cambiare, se solo sapesse da dove cominciare)
Questa è una frase tipica di chi ha smesso di cercare spiegazioni, di chi si è identificato con le proprie ferite. È il tentativo di dare senso a qualcosa che non ha avuto contenimento. Dietro a questo “sono fatto così” si cela spesso una storia di adattamenti e negazioni, di bisogni sepolti per sopravvivere.
Nel linguaggio della psicoanalisi, si parla di “fissazione dell’Io”: l’individuo rimane incastrato in una forma di sé che ha costruito per proteggersi, ma che ora lo limita. È il “falso sé” di Winnicott: quella maschera funzionale che prende il posto dell’autenticità quando non ci sentiamo al sicuro.
9. “Io non ho bisogno di nessuno”
(Ma in fondo desidera essere cercato, anche se non lo chiede)
L’autarchia emotiva è un altro effetto della trascuratezza infantile. Quando il legame ha deluso, tradito o ignorato, l’unica via per proteggersi è negare il bisogno. Ma il bisogno non scompare: si nasconde, si trasforma, a volte implode sotto forma di ansia o depressione.
“Io non ho bisogno di nessuno” è una corazza. Ma sotto, c’è sempre un cuore che desiderava solo essere amato. Dal punto di vista neurobiologico, questo atteggiamento si accompagna a un’alterazione del sistema ossitocinico: il neurotrasmettitore del legame, della fiducia, viene silenziato da una storia di assenze.
10. “Mi faccio andare bene tutto”
(Ma sogna di poter dire un giorno: “Questa volta scelgo me”)
Chi è stato trascurato da piccolo ha imparato che esprimere desideri è pericoloso, che dire “no” allontana l’amore. Così si accontenta. Si adatta a relazioni che non lo nutrono, a lavori che non lo rappresentano, a vite che non lo somigliano. Il compromesso diventa identità.
“Mi faccio andare bene tutto” è la frase di chi ha rinunciato a sé stesso per restare in contatto con l’altro. È la voce sommessa di una ferita: quella di chi, da piccolo, ha ricevuto amore solo a condizione di non disturbare, di non essere troppo. Un amore condizionato, che lascia segni profondi.
Che tipo di genitore ha avuto chi è stato trascurato emotivamente
La trascuratezza emotiva non sempre ha il volto riconoscibile della violenza o dell’abbandono conclamato. Spesso, è molto più sottile. Si manifesta nell’assenza silenziosa di uno sguardo che comprende, di una voce che consola, di un gesto che contiene. È fatta di piccole mancanze ripetute, di frasi non dette, di abbracci non dati.
È, a tutti gli effetti, un accumulo di microtraumi relazionali: eventi apparentemente innocui, ma che nel tempo compromettono il senso di sé, la fiducia negli altri e la capacità di riconoscere i propri bisogni emotivi.
Chi è stato trascurato emotivamente ha spesso avuto genitori presenti nel corpo, ma assenti nella mente e nel cuore.
Genitori che si occupavano delle cose pratiche – la cena, la scuola, i vestiti – ma erano emotivamente scollegati. Non chiedevano mai: “Come stai davvero?”. Non si accorgevano del cambiamento nello sguardo, del tremolio nella voce, del bisogno nascosto dietro un silenzio.
A volte si tratta di genitori anestetizzati dalla loro stessa infanzia, adulti che non hanno mai imparato a riconoscere le emozioni – né le proprie, né quelle degli altri. Altre volte sono genitori iperfunzionali, che credono che basti “fare” per amare, e non sanno “esserci”.
Ci sono anche genitori ipercritici, instabili, imprevedibili: capaci di alternare freddezze improvvise a slanci confusi. E poi ci sono quelli che non hanno mai ferito apertamente, ma neppure accolto, contenuto, rassicurato. Genitori che non hanno fatto “niente” – ed è proprio questo il problema.
Crescendo in questo tipo di ambiente, il bambino sviluppa strategie di adattamento invisibili, ma potentissime: si convince che i suoi bisogni siano un peso, che le sue emozioni vadano contenute, che il suo dolore non sia degno di ascolto. Il cervello impara a ignorare le richieste interne, il cuore a sopportare in silenzio.
E così, quando diventa adulto, quelle assenze si traducono in un linguaggio quotidiano fatto di frasi che raccontano tutto quello che non è stato detto, tutto quello che non è stato dato. (Questo aspetto lo approfondirò nel prossimo articolo).
Imparare a dire ciò che non si è mai detto
Ogni frase che hai letto finora può essere un indizio. Un segnale che qualcosa, un tempo, è mancato. Ma riconoscerlo è già il primo passo verso la guarigione. Perché le parole possono anche curare, se usate per dire finalmente ciò che da bambini non si è potuto dire.
Ritrovare la voce è un processo profondo, ma possibile. Vuol dire imparare a dire “ho bisogno”, “mi fa male”, “non mi basta”, senza più sentirsi sbagliati. Significa offrire a sé stessi quel contenimento emotivo che è mancato. Vuol dire costruire una nuova narrazione, in cui non sei più il bambino che si adatta, ma l’adulto che si sceglie.
Nel mio libro “Il mondo con i tuoi occhi”, parlo proprio di questo: di come le parole che usiamo siano un riflesso di ciò che abbiamo vissuto, ma anche uno strumento potente per riscrivere la nostra storia. Dentro di te, c’è ancora quel bambino. E merita di essere ascoltato. Il mio libro è disponibile in libreria e qui su Amazon
E se ti va, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe.
Ti aspetto lì per continuare il viaggio.