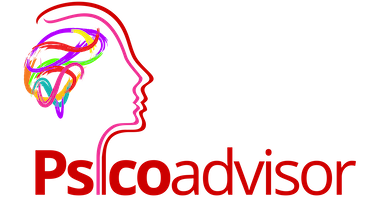“È passato tanto tempo.”
“È passato tanto tempo.”
“Erano altri tempi.”
“I miei genitori hanno fatto del loro meglio.”
“Ormai non ci penso più.”
Quante volte lo diciamo. Con voce ferma, a volte con un mezzo sorriso, a volte con una scrollata di spalle che chiude il discorso prima ancora che possa aprirsi davvero. Eppure, nel corpo, nei sogni, nelle relazioni che scegliamo o da cui non riusciamo a fuggire, l’infanzia continua a parlare. Non lo fa con parole dirette, ma con sintomi, reazioni, autosabotaggi. Con quel dolore che si infiltra dove meno ce lo aspettiamo, soprattutto quando ci convinciamo che ormai non ci riguarda più.
Crescere in una famiglia imperfetta non significa necessariamente aver vissuto tra abusi o violenze esplicite
Spesso, le ferite più profonde nascono da ciò che non c’è stato: uno sguardo che non arrivava mai, una carezza che aspettava invano, una voce che ci ha fatto sentire sbagliati proprio quando avevamo più bisogno di sentirci accolti.
Ma riconoscerlo è difficile. Soprattutto se siamo cresciuti imparando che amare significa giustificare, che “poteva andare peggio”, che “in fondo siamo forti”.
E così, per difenderci dal dolore, impariamo a mentire a noi stessi.
Non con cattiveria, ma per sopravvivere.
Queste frasi che ci ripetiamo non sono solo parole: sono strategie inconsapevoli, forme di adattamento emotivo. E, paradossalmente, più ci aggrappiamo a queste frasi, più restiamo incatenati a un passato che non sappiamo di star portando ancora con noi.
Le frasi che raccontano una bugia (ma ci salvano dal crollo)
Esploriamo ora alcune delle frasi più comuni che le persone si raccontano per non affrontare un’infanzia difficile. Lo faremo non per giudicarle, ma per capirle. Perché ogni frase che nega il dolore, in realtà, ci racconta anche quanto abbiamo avuto bisogno di proteggerci.
1. “In fondo, i miei genitori hanno fatto del loro meglio”
È forse la frase più comune, e la più difficile da scardinare. Perché può anche essere vera. Ma qui non si tratta di giudicare i genitori: si tratta di riconoscere l’effetto che hanno avuto su di noi.
Prendi nota: La verità è che si può essere grati e feriti allo stesso tempo.
2. “Ormai è passato”
Il tempo non guarisce, se non è attraversato. Il nostro sistema nervoso, le nostre emozioni, non hanno un calendario: se un’esperienza non è stata elaborata, rimane presente sotto forma di ipercontrollo, ansia, dissociazione o bisogno costante di approvazione.
Prendi nota: Dire che è passato è un modo per evitare il contatto con il dolore. Ma quel dolore, intanto, continua a parlarci da dentro.
3. “Sono diventato forte proprio grazie a quello che ho vissuto”
La resilienza è meravigliosa. Ma quando viene usata per coprire le ferite, rischia di diventare una corazza che ci impedisce di sentire.
Prendi nota: Non ogni ferita è una lezione. Alcune sono solo ferite. E meritano cura, non trasformazioni forzate in forza.
4. “Tutti hanno avuto problemi, non è che la mia infanzia fosse peggiore”
Confrontarsi con le storie degli altri è un modo per minimizzare il proprio dolore. Ma il trauma non si misura in termini assoluti: è sempre soggettivo.
Prendi nota: Ogni bambino ha il diritto di sentire che ciò che ha vissuto lo ha segnato, anche se non è stato il peggiore degli scenari.
5. “Non voglio parlarne, ormai non serve a nulla”
Il silenzio è una strategia. Serve, eccome. Serve a tenere insieme pezzi che altrimenti crollerebbero. Ma a lungo andare, diventa una prigione.
Prendi nota: Parlare non riapre il dolore. Lo libera.
6. “I miei genitori erano così perché anche loro hanno sofferto”
Comprendere la storia dei nostri genitori è importante. Ma non può diventare una giustificazione che cancella i nostri bisogni emotivi non soddisfatti.
Prendi nota; La compassione verso gli altri non dovrebbe venire a scapito della compassione verso sé stessi.
7. “Sono io che ero troppo sensibile”
Una frase che spesso deriva da anni di invalidazione emotiva. Quando un bambino sente dire che “esagera”, che “fa storie”, che “non è niente”… finisce per credere che il problema sia lui.
Prendi nota: La sensibilità non è il problema. È l’ambiente che non l’ha contenuta a esserlo.
Perché vogliamo proteggere la nostra infanzia: uno sguardo psicoanalitico
In psicoanalisi si osserva spesso che le difese più rigide non proteggono tanto il dolore, quanto l’illusione dell’amore ricevuto. Se ammettiamo che la nostra infanzia è stata difficile, rischiamo di mettere in discussione l’intero fondamento identitario su cui ci siamo costruiti: quello del bambino che ha ricevuto amore, che è stato visto, accolto, voluto.
Ma soprattutto, c’è un altro timore più profondo e spesso inconscio: che se l’amore che ci è mancato fosse reale, allora forse non lo meritavamo.
Il bambino, per natura, non può pensare che l’adulto sbagli. Se mamma o papà non lo vedono, non può credere che loro siano emotivamente inadeguati. Allora cosa fa?
Si attribuisce la colpa. Si convince che è lui a non essere stato abbastanza: abbastanza calmo, abbastanza forte, abbastanza intelligente, abbastanza degno. Questa dinamica è alla base del concetto freudiano di super-io punitivo: una parte interna che interiorizza il giudizio e lo rende costante, pericolosamente familiare.
Così, crescendo, molti adulti non possono permettersi di dire:
“Non sono stato amato nel modo giusto.”
Perché subito dopo arriverebbe il pensiero più devastante:
“Forse non ne ero degno.”
E allora si attivano le bugie difensive. Non per falsità, ma per sopravvivenza emotiva.
I bambini non possono permettersi di odiare i genitori, perché dipendono da loro. Ma da adulti, spesso, continuiamo a proteggerli anche quando potremmo finalmente guardare la verità.
Perché se ammettiamo che ciò che ci hanno dato non bastava, dobbiamo anche fare i conti con il fatto che siamo cresciuti in una carenza d’amore. E questo fa ancora male.
Nel pensiero di Winnicott, il bisogno del bambino di adattarsi al genitore (più che essere accolto per quello che è) lo porta a formare un falso sé. Questo falso sé, da adulto, continua a sostenere narrazioni accomodanti:
- “Era per il mio bene.”
- “Ero troppo sensibile.”
- “Non ho motivi reali per lamentarmi.”
Ma sono proprio queste frasi che bloccano il lavoro analitico profondo. Perché se proteggi il genitore idealizzato, non puoi prenderti cura del bambino reale che sei stato.
Ecco perché il lavoro psicoterapeutico diventa, spesso, un atto di disidealizzazione. Non per distruggere l’immagine dei genitori, ma per riconquistare il diritto a sentire. A sentire rabbia, tristezza, bisogno, delusione. Sentire tutto ciò che da bambini abbiamo dovuto reprimere per restare “al sicuro”.
Cosa succede quando iniziamo a smettere di mentire?
Quando finalmente ci permettiamo di dire la verità a noi stessi, accade qualcosa di straordinario. Non crolliamo, come temevamo. Ci alleggeriamo. Perché il dolore che non nominiamo ci tiene prigionieri, ma quello che riconosciamo diventa accessibile, trasformabile, digeribile.
Riconoscere la propria infanzia difficile non significa colpevolizzare nessuno. Significa riconoscersi. Dare dignità a quel bambino che ha vissuto troppo presto, ha sentito troppo, ha avuto bisogno e non ha trovato. Significa non dover più scegliere tra amare i propri genitori o amare sé stessi.
Un esercizio di verità
Puoi iniziare con una domanda semplice, ma potente:
Quale frase mi sono ripetuto per non soffrire?
Scrivila. Poi scrivi la verità che stai cominciando a sentire sotto quella frase. Anche se è scomoda. Anche se fa paura.
E chiediti:
Cosa stava cercando di proteggere quella frase?
Che bisogno nascosto non ho mai potuto nominare?
A volte non serve capire tutto, basta iniziare ad ascoltarsi. Anche solo un po’.
Conclusione: la bugia finisce quando nasce la compassione
Ogni bugia che ci raccontiamo sull’infanzia ha radici nella paura. La paura di non reggere, di crollare, di restare soli in quel dolore. Ma oggi non siamo più soli. Abbiamo parole, strumenti, adulti consapevoli intorno — o dentro di noi. E possiamo prenderci per mano, anche tardi. Possiamo guardarci con tenerezza e dire: “Quello che hai vissuto conta. E meriti di guarire.”
Se senti che qualcosa dentro di te ha iniziato a muoversi leggendo questo articolo, sappi che c’è un modo per continuare a lavorare su di te. Nel mio libro “Il mondo con i tuoi occhi”, ho raccolto strumenti clinici, esperienze trasformative e prospettive psicoanalitiche per aiutarti a dare voce al tuo passato e costruire una vita più autentica, libera dai condizionamenti e fedele al tuo sentire profondo. Non per cambiare chi sei, ma per tornare finalmente a riconoscerti. Per immergerti nella lettura e farne tesoro, puoi ordinarlo qui su Amazon oppure in qualsiasi libreria
A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoasvisor
Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe