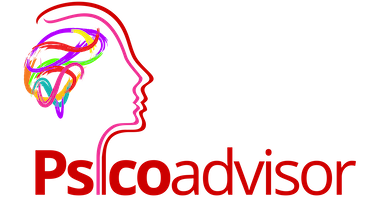Se potessimo fermarci un attimo — solo un attimo — a guardare quel minuscolo corpo che respira da poco, quel piccolo cuore che già conosce il battito del mondo… Forse sentiremmo parole semplici, disarmanti. Parole che non sono ancora suoni, ma che urlano forte dal corpo, dalla pelle, dagli occhi.
«Tieni la mia fragilità tra le mani, senza paura. Io sono nuovo qui
Non so ancora come si fa a vivere, ma so già cosa mi serve per crescere: sicurezza, ascolto, amore che non fa rumore.
Non sono qui per adattarmi ai vostri ritmi frenetici, ai vostri copioni di perfezione. Sono qui per esistere. E per farlo ho bisogno di te, della tua presenza vera, non perfetta.
Quando piango, non ti sto sfidando. Ti sto chiamando. Sto dicendo: “Aiutami a capire cosa mi succede”.
Accogli il mio pianto come il primo linguaggio del mio cuore. Non ho altri modi per dirti che ho fame, che ho freddo, che ho paura, che mi sento solo.»
Se potesse parlare, un neonato ci chiederebbe questo: di non avere fretta di zittirlo. Di non avere l’urgenza di consolarlo solo per spegnere il nostro disagio. Di restare, semplicemente restare, accanto al suo bisogno.
Perché ogni bambino che nasce porta già con sé un sapere antico: quello di chi conosce il valore di essere accolto, prima ancora di essere educato. Eppure, troppo spesso, siamo noi adulti a non essere pronti a reggere quel bisogno. A volte, senza accorgercene, chiediamo ai bambini di imparare troppo presto a “non sentire”, a “non disturbare”, a “non essere troppo”. Ma l’anima di un neonato ci insegna, silenziosamente, che crescere non è imparare a smettere di sentire. Crescere è imparare a tenere insieme le emozioni, senza paura.
Il bisogno più grande: sentirsi al sicuro
Se potesse parlarti, un bambino appena nato non ti chiederebbe giocattoli, non ti chiederebbe parole difficili. Ti chiederebbe una cosa sola: “Fammi sentire al sicuro.”
Nel linguaggio della neurobiologia, il bisogno di sicurezza si traduce nel bisogno di regolazione del sistema nervoso. Alla nascita, infatti, il cervello del bambino è ancora immaturo: le aree preposte all’autoregolazione emotiva, come la corteccia prefrontale, sono in costruzione. Per questo il neonato si affida completamente a chi si prende cura di lui per imparare a regolare il proprio stato interno.
In psicologia si parla di coregolazione: la capacità del caregiver di fare da “specchio calmo”, di contenere e modulare le emozioni del bambino, restando presente anche di fronte al pianto, alla rabbia, alla paura. Non è un semplice accudimento fisico, è qualcosa di più profondo: è il modo in cui il bambino, attraverso il corpo e la voce di chi si prende cura di lui, sperimenta che il mondo è un luogo abitabile, che c’è qualcuno capace di stare con lui nei momenti difficili senza andare in pezzi.
Questo bisogno di sicurezza non è un lusso, non è una coccola in più: è un nutrimento biologico ed emotivo essenziale. Gli studi di neuroscienze affettive, come quelli di Allan Schore, hanno mostrato che le esperienze di attaccamento sicuro favoriscono uno sviluppo armonioso del cervello, in particolare delle aree coinvolte nella regolazione dello stress e delle emozioni, come l’amigdala, l’ippocampo e la corteccia prefrontale.
È proprio grazie alla sintonizzazione emotiva tra adulto e bambino che si gettano le basi di un sistema nervoso resiliente: un sistema capace di reggere la frustrazione, l’attesa, la delusione, senza precipitare nello stato d’allarme. Quando il bambino incontra uno sguardo che lo comprende e una presenza che lo calma, il suo cervello impara, a poco a poco, a distinguere il pericolo reale da quello immaginato, e a ritrovare l’equilibrio anche dopo un momento di turbamento.
Un bambino non ha bisogno di adulti perfetti, ma di adulti regolati. Di adulti che, nel momento in cui il pianto li attiva, riescono a respirare, a fermarsi, a chiedersi: Di cosa ha bisogno, adesso, questo piccolo cuore? Di cosa ho bisogno io, per restare presente?” Perché la sicurezza non è solo quella delle mura di casa. È la sicurezza di uno sguardo che dice:
“Qualunque cosa tu senta, io ci sono.”
Imparare ad accogliere le emozioni: il primo dono che possiamo fare
Se potesse, un bambino appena nato ti direbbe: “Non avere paura delle mie emozioni.” Troppo spesso, anche senza volerlo, ci avviciniamo al disagio dei bambini con l’urgenza di “calmarli”, di far smettere quel pianto che ci smuove dentro. Ma il pianto di un neonato non è un nemico da zittire: è il primo linguaggio dell’anima, il primo modo per dire “Ho bisogno”, quando ancora le parole non ci sono.
Secondo la teoria dell’attaccamento di John Bowlby, la presenza stabile e sintonizzata di una figura di riferimento consente al bambino di sviluppare un modello operativo interno basato sulla fiducia: l’idea che le emozioni, anche quelle spiacevoli, possono essere espresse senza temere l’abbandono o il giudizio.
Quando un bambino incontra un adulto capace di stare con lui nella fatica senza scappare, senza distrarsi, senza zittire… sta ricevendo un dono prezioso: sta imparando che le emozioni non sono pericolose. Che possono essere attraversate, comprese, regolate.
Dal punto di vista neuroscientifico, questo processo è fondamentale per lo sviluppo delle connessioni tra l’amigdala — il centro della paura e dell’allarme — e la corteccia prefrontale, che ci aiuta a dare un senso alle nostre emozioni e a modularle. Ogni volta che accogliamo il pianto senza fretta, ogni volta che nominiamo le emozioni (“Sei arrabbiato”, “Ti sei spaventato”, “Sei triste”), contribuiamo alla costruzione di queste connessioni.
Ma attenzione: accogliere le emozioni non significa sempre “risolverle”. Non sempre possiamo eliminare il disagio di chi abbiamo davanti — e, a dire il vero, non è nemmeno ciò di cui ha bisogno un bambino. Quello di cui ha bisogno è sapere di non essere solo nella tempesta. Sapere che c’è una mano pronta a reggere la vela insieme a lui.
Non insegnarmi a non sentire, insegnami a stare con ciò che sento
Se potesse, ogni bambino ti direbbe: “Non chiedermi di essere sempre calmo, non chiedermi di essere sempre felice.”
Nel nostro mondo, ancora troppo spesso, l’educazione emotiva viene confusa con il controllo delle emozioni: “Non piangere”, “Non arrabbiarti”, “Non essere triste”. Ma il benessere psicologico non nasce dalla repressione delle emozioni. Nasce dalla loro integrazione.
Daniel Siegel, nella sua teoria del cervello integrato, parla della necessità di collegare le diverse parti del nostro essere: la parte razionale con quella emotiva, il sentire con il pensare. E questo processo di integrazione inizia già nei primi mesi di vita, attraverso la relazione con chi si prende cura di noi.
Ogni volta che, invece di dire “Non piangere”, diciamo “Capisco che sei triste”, stiamo aiutando quel bambino a dare un nome al proprio mondo interno, a costruire le mappe che un giorno gli permetteranno di orientarsi tra le onde delle sue emozioni senza annegare. Questo è il primo passo verso una vera intelligenza emotiva: non il dominio sulle emozioni, ma la capacità di stare con loro, di ascoltarle, di comprenderne il messaggio.
Il primo dialogo d’amore: io ti vedo, io ci sono
Se potesse, un bambino appena nato non chiederebbe grandi discorsi. Ti direbbe solo:“Guardami. Resta.”
E forse questo, alla fine, è il bisogno che portiamo dentro tutta la vita. Sentire che c’è qualcuno che resta, anche quando siamo fragili, anche quando non abbiamo ancora imparato a tradurre in parole quello che ci accade. Accogliere un bambino non significa proteggerlo da ogni difficoltà. Significa stare con lui nel viaggio delle emozioni, senza fretta di arrivare, senza paura di perdersi.
Perché il primo insegnamento di ogni neonato, se solo potessimo ascoltarlo, è questo: “Non guarirò dalla mia fragilità, perché è lei che mi rende umano. Aiutami a farne il mio punto di forza.”
Crescere è imparare a sentirsi a casa dentro di sé
In fondo, tutto questo — il bisogno di sicurezza, il diritto di sentire, la possibilità di essere accolti senza condizioni — non riguarda solo i bambini. Riguarda ciascuno di noi. Perché il modo in cui siamo stati visti, ascoltati, rassicurati nei primi anni di vita resta scritto dentro il corpo, nei circuiti del cervello, nel dialogo che ogni giorno intratteniamo con noi stessi.
E così accade che molti adulti si ritrovino a vivere portandosi addosso una domanda silenziosa: “Sono abbastanza, anche quando non sorrido? Sono degno di amore, anche quando sono fragile?”
Quando non abbiamo potuto imparare a riconoscere e accogliere le nostre emozioni fin da piccoli, rischiamo di passare la vita intera cercando di “aggiustarci”, di zittire quella parte di noi che chiede solo di essere ascoltata. Eppure non è reprimendo ciò che sentiamo che si cresce. È imparando a dare un posto, un nome, uno spazio sicuro a ogni parte di noi.
Nel mio libro, “Il mondo con i tuoi occhi”, parlo proprio di questo: di come spesso inseguiamo modelli di felicità che non ci appartengono, imparando a ignorare i nostri bisogni autentici. E di quanto sia invece necessario ritornare a guardare la vita con uno sguardo libero dai condizionamenti, capace di accogliere le emozioni come alleate, non come nemiche.
Perché crescere — davvero — non significa imparare a non sentire. Significa imparare a sentire senza paura, a restare presenti a ciò che accade dentro di noi, a costruire una casa interiore che non giudica, che non respinge, che sa dire:
“Qui, con tutte le tue emozioni, sei al sicuro.” Per immergerti nella lettura e farne tesoro, puoi ordinarlo qui su Amazon oppure in qualsiasi libreria
A cura di Ana Maria Sepe, psicologo e fondatrice della rivista Psicoasvisor
Se ti piace quello che scrivo, seguimi sul mio profilo Instagram: @anamaria.sepe